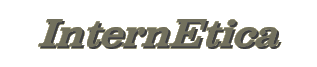 |
|||||||
|
|
|||||||
|
Il velo proibito “con le
vostre leggi democratiche vi conquisteremo, Un problema complessoSul caso del chador nelle scuole francesi gran parte del mondo cattolico ha espresso forti riserve verso un provvedimento in cui si è vista una confusione tra una sana laicità e un insano laicismo (così, tra gli altri, M.Introvigne, autorevole esperto di religioni nella società contemporanea). Noi non ci sentiamo di proporre una valutazione esauriente, perché davvero il problema non è semplice. Vorremo però provare a fare il punto sul caso, che è emblematico della problematica della integrazione, mostrandone appunto la complessità. Contro la libertà religiosa?Una prima possibile linea di lettura della scelta è quella che la iscrive nella lunga storia del laicismo (già anticlericale) dei nostri vicini d’Oltralpe[1]. Si tratterebbe di limitare la libertà religiosa (di limitarla a una “modica quantità”, direbbe Introvigne), in nome di quella sorta di religione laica, chiamata laïcité (laicità), che costringe le religioni dentro una sfera strettamente privata, ritenendo che solo lo Stato e i valori civili possano fungere da garanzia di coesione sociale, libertà e eguaglianza. Così Introvigne nota che
Non si può in effetti negare che una componente del sottofondo motivazionale del provvedimento sia di matrice laicista. C’è, ad esempio nel discorso di Chirac, una enfasi quasi sacralizzante nella sottolineatura della Repubblica e dell’idea repubblicana:
Attenti all'effetto alonePerò non vorremmo che certe reazioni alla scelta francese fossero troppo condizionate dal passato, dalla solita vecchia polemica Chiesa/Stato, annosa in Francia. Non vorremmo che, in perfetta buona fede, agisse una sorta di effetto alone, per cui, avendo un certo soggetto agito per 99 volte in un certo modo (laicisticamente, nella fattispecie), si dia per scontato che anche la centesima volta agirà in quel modo, senza esaminare bene lo specifico di quella centesima volta. Guardando troppo a un nemico passato (il vecchio laicismo anticlericale) si rischierebbe allora di sottovalutare il pericolo nuovo, il fondamentalismo. L'oggettivo è oggettivoMa quand’anche fosse certo che la motivazione fosse fondamentalmente una volontà di limitare la libertà religiosa, resterebbe il dovere di esaminare il provvedimento in sé stesso, nella sua oggettività. Anche perché, se in campo etico la motivazione è fondamentale (tanto che una buona azione fatta per una cattiva l’intenzione non ha valore meritorio), in campo politico invece gli atti (esterni) hanno un loro valore oggettivo, una loro vita autonoma, che può anche prescindere dalle intenzioni, in base a cui sono compiuti da chi li compie. E la Chiesa lo sa. Un esempio che mi viene è quello del Concordato tra la S.Sede e la Germania, nei primissimi tempi in cui Hitler la guidava: è difficile pensare che la Chiesa ignorasse che le intenzioni con cui Hitler firmava non fossero del tutto positive; ma ciò non le ha impedito di incassare un vantaggio da un atto che aveva comunque una sua oggettiva validità, a prescindere dall’intenzione di chi lo compiva. Non per niente Vico parlava di eterogenesi dei fini, del resto. Quale può essere allora una (una, si badi, non dico l’unica) valenza oggettiva, nel senso precisato, del divieto del chador? Non una limitazione della libertà religiosa. Non viene proibita una espressione religiosa, ma una politica. Dove finisce la religione e comincia la politicaVediamo di precisare i termini in questione. Che cosa si deve intendere per religione? Quella sfera che riguarda il rapporto tra la persona e il suo Destino ultimo e trascendente. Dove invece interviene come fattore determinante e discriminante l’organizzazione della società, a prescindere anche dalla convinzione e dalla libertà della persona, non si ha più a che fare con la sfera religiosa, ma con quella politica. Si sa che per il Cristianesimo i rapporti comunionali sono importantissimi, anzi decisivi, ma sempre e solo come rapporto tra persona e persona (in ultima analisi tra persona e Persona), dove il fattore consapevolezza e il fattore libertà sono determinanti[2]. Nel caso dell’Islam invece si dà una mescolanza tra una dimensione propriamente religiosa, che trova nel sufismo[3] la sua punta di diamante più limpida, e dimensione politico-totalizzante. Nella prima dimensione vi è l’idea che ogni persona deve essere libera di rapportarsi al suo Destino, e che non avrebbe senso forzare tale rapporto; nella seconda invece, prevalendo sulla prospettiva personale quella di organizzazione politica della società, l’importante è che la società sia organizzata in base a certi principi, anche forzando le persone a piegarvisi, senza vera convinzione e senza libertà. Così nella storia dell’Islam questa seconda dimensione, largamente prevalente del resto, ha comportato quello che chiamiamo progetto totalitario, forzando pesantemente la conversione all’Islam, con strumenti fiscali (tasse speciali ai non-mussulmani), giuridici (diverso trattamento per credenti e “infedeli”, ad esempio asimmetrica invalidità della testimonianza di questi ultimi contro i mussulmani, diseguale punizione di reati perpetrati a fedeli o a infedeli[4], proibizione della “sconversione" dall’Islam e della “propaganda” di altre fedi e via dicendo) e talora militari (uccisione degli infedeli meno assimilabili all’Islam, ad esempio idolatri e politeisti, ma non di rado anche cristiani ed ebrei[5]). Oggi, questa dimensione politico-totalitaria è ripresa dal fondamentalismo islamico, che gli conferisce, com’è noto, un accento di violenta aggressività. Il chador, secondo Samir[6], è appunto espressione del fondamentalismo, dunque non è una espressione di religiosità, ma di una neoplasia politica pseudo-religiosa. Non si tratta perciò di limitare le religioni, ma una religione, e solo ed esattamente nella misura in cui non è una religione, cioè solo nella sua sporgenza non-religiosa, nella sua eccedenza politica, nel suo straripamento totalitario. Si tratta cioè di limitare l’Islam, non in quanto religione, ma in quanto progetto politico totalizzante e totalitario. Dell’Islam non viene toccata la religiosità, ma l’arrogante invadenza politica. A venir vietato non è un simbolo religioso, ma un simbolo pseudo-religioso. Così, stando anche alla definizione di laicismo proposta da Introvigne, sopra citata, oggettivamente non si da proibizione “ai credenti di manifestare la loro fede sia in pubblico sia nella vita pubblica”, per la semplice ragione che ciò che è proibito non manifesta la fede, ma un progetto politico totalitario. Conferme autorevoliChe non venga toccata la dimensione propriamente religiosa è provato dal fatto, che secondo autorevoli islamologi, il velo non è prescritto dal Corano, e non si può considerare parte integrante della dimensione religiosa islamica. Lo dice Khalil Samir:
Lo conferma il teologo mussulmano Khaled Fouad Allam:
Ulteriore conferma viene dal fatto anche dei paesi mussulmani hanno proibito il velo, come Turchia, Siria e Tunisia. E autorevoli intellettuali islamici moderati criticano l’isteria con cui molti hanno accolto la decisione francese. Ad esempio, ricorda Samir «in Francia, mentre migliaia di donne manifestavano contro il progetto di legge, il muftì di Marsiglia, Soheib Bensheikh, le ha accusate di fare il gioco di “quei falsi religiosi che usano la laicità come un cavallo di Troia per favorire l’islamismo politico e oscurantista”.» E, aggiunge sempre Samir, in Egitto il rettore dell’università di Al-Azhar (al Cairo), «Muhammad Sayyid Tantawi, ha dichiarato libera dall’obbligo di portare il velo la donna musulmana che vive in uno stato non islamico che lo proibisce.» contro un progetto politico totalitario!Se non è un attacco all’Islam come religione, il divieto del chador lo potrebbe essere però all’Islam come progetto totalitario. Sentiamo ancora Samir: il senso del divieto è quello di
Che cosa è come se dicesse, insomma, chi porta il velo? Implicitamente dice “io voglio islamizzare questa terra”. Dove islamizzare indica non solo e non tanto rivolgersi alla libertà delle persone convincendole liberamente, e ammettendone una reversibilità di scelta[7], della bontà dell’Islam come rapporto col Mistero trascendente, ma imporre a livello politico una irreversibile e non criticabile struttura della società in base alla legge coranica. Se è così, se il velo non appartiene alla dimensione religiosa, ma a una invasiva tumefazione politica dell’Islam radicale e fondamentalista, quali che siano le motivazioni soggettive di Chirac, il divieto del chador ha (anche, se non altro) una oggettiva valenza antifondamentalista e antitotalitaria. Se è così, infatti, il provvedimento potrebbe essere letto in una valenza di autodifesa politica, ben più che di repressione antireligiosa. In termini che si potrebbero riassumere così: la Francia, fondata su certi valori, di democrazia, eguaglianza, libertà e tolleranza, non può tollerare che si esibisca qualcosa, che simboleggia una visione politica che, se vincesse, distruggerebbe la democrazia e la tolleranza. La Francia “repubblicana” - oggettivamente, ripetiamolo - non tollera l’intolleranza. Non dà spazio democratico a chi vorrebbe sopprimere la democrazia. Il problema allora non sarebbe una intolleranza antireligiosa, ma un’autodifesa politica (maldestra e discutibile quanto si vuole nei mezzi scelti). AnalogieE vi agirebbe così lo stesso principio in base al quale i Costituenti italiani, nel ’47, vietarono la ricostituzione del Partito Fascista: tutti i partiti sono ammissibili, tranne quelli la cui unica ragion d’essere è di eliminare tutti gli altri. Vi agirebbe, ancora, la stessa logica per cui Locke, teorico del liberalismo moderno e antiassolutista convinto, riteneva lecito che uno stato liberale tutto tollerasse, fuorché chi minacciava la sua stessa esistenza. Se è così, il divieto del chador assume lo stesso valore del divieto di esibizione della svastica. Se è infatti lecito stroncare sul nascere il neonazismo, in quanto nemico mortale del sistema democratico, non si vede perché lo stesso principio non dovrebbe valere per qualunque altro nemico mortale del sistema democratico. Una buona tattica?Se quanto al fine si può trovare una valenza oggettiva plausibile, ossia uno sbarramento opposto al fondamentalismo come progetto politico totalitario, si può comunque dire che i mezzi scelti siano adeguati? Si può in effetti discutere se il chador sia il massimo segno di un progetto politico aggressivo e intollerante. Sentiamo ancora Samir, che elenca altri esempi analoghi:
È pur vero che anche per tali casi, sono state o sono in via di approvazione in Francia, altre disposizioni analoghe al divieto del velo. Ci sono varie obiezioni comunque, precisamente, sul tema del velo. Che apparentemente, vuoi perché portato da ragazze, e dunque difficilmente associabile a un’idea di violenza e aggressività, vuoi per il suo richiamare un’immagine di inoffensiva pudicizia, quasi assimilabile all’abbigliamento delle religiose cattoliche, non risulta facilmente associabile al fondamentalismo, e sembrerebbe invece proprio un simbolo religioso. Il fatto che un autorevole conoscitore dell’Islam come Khalil Samir sostenga che il chador è, di fatto, espressivo del fondamentalismo, ci pare però un serio motivo di riflessione. Confermato dalle altre opinioni di esperti, sopra citate. E confermato anche dal fatto che la diffusione del velo è proceduta in parallelo con la diffusione del fondamentalismo, al punto che, come ammette Introvigne, non sono rari i casi in cui il velo viene portato dalle figlie, e non dalle madri. Non si tratta insomma di una tradizione, che viene, come dire, pietosamente conservata, ma di una novità, che denota un’ideologia nuova, cioè appunto, per quanto apparentemente mite ne sia l’aspetto, il fondamentalismo aggressivo. Anche il fatto che Al Quaida abbia minacciato la Francia a motivo della proibizione del chador sembrerebbe indicare che un legame tra chador e fondamentalismo esiste. Probabilmente una valutazione
equilibrata della questione dovrebbe dire così: il chador, intrinsecamente
e di diritto, non è un simbolo politico (fondamentalista-totalitario), o
almeno lo è solo di riflesso e indirettamente; storicamente e di
fatto, però, lo è. Oggi, se non altro, lo è. È probabilmente corretto dire
che è diventato un simbolo di un Islam antioccidentale e intollerante. E ciò
non accade in seguito alla recentissima decisione francese, ma nel corso degli
ultimi decenni del '900.
Oltre facili irenismiPuò comunque darsi che il bersaglio sia mal scelto. Anzi probabilmente lo è. Quello però che ci sembra legittimo e auspicabile è che gli stati occidentali diano dei segnali forti della loro volontà di accettare sì una pluralità di credenze religiose, salvaguardando la libertà religiosa, ma non un progetto politico totalitario e antidemocratico. Ed escano dalla trappola del relativismo politically correct, che è, come dice Samir, “un cavallo di Troia” del progetto fondamentalista. Occorre anche capire che questi segnali non possono essere indolori: dobbiamo superare una certa idea di irenismo imbelle. Certo, coltivando anche il dialogo con l’Islam moderato e usando tutto l’equilibrio e la duttilità richiesti da una problematica complessa. Ma il timore che, contrastandolo frontalmente, si alimenti ulteriormente il fondamentalismo, non ci convince. Citiamo ancora Samir:
Con chi ce l'ha il fondamentalismo?Anche perché il bersaglio del fondamentalismo non è un sistema occidentale che vieta il chador, ma ogni sistema che non sia ispirato al Corano, vieti o non vieti il velo. Non è che il fatto di non vietare il chador renda un sistema politico-culturale accettabile al fondamentalismo, se resta non islamico. Con o senza il divieto, per il fondamentalismo il sistema occidentale va abbattuto. E chi “diventa” fondamentalista trova in altre cause, molto meno facilmente modificabili di un divieto, un alimento alla sua radicalizzazione, pensiamo ai costumi secolarizzati della società occidentale, nella pornografia ad esempio, o nella crisi della famiglia e giù di lì. Paragoni impropriEvocare, come fa un amico, il caso della Bosnia, dove fino alla guerra esisteva una pacifica convivenza, con un Islam moderato e aperto, mentre i massacri perpetrati dai Serbi hanno provocato una radicalizzazione dell’Islam, non appare pertinente: tra il massacrare migliaia di persone e il proibire il velo, come tra l’altro hanno già fatto paesi mussulmani, quali Turchia, Siria e Tunisia, ci sembra esista una bella differenza. Se nel primo caso una radicalizzazione è plausibile, nel secondo essa si configurerebbe più come l’esplicitazione, forse neanche del tutto negativa perché chiarificatrice[8], di un implicito già serpeggiante, che non come l’effetto di una causa esterna. Un problema laicoC'è un punto della questione che ci sembra vada chiarito: quello del chador non è, anzitutto e soprattutto, un problema delle autorità confessionali (cristiane o no). Non è, per essere più chiari, un problema affidato all'autorità della Chiesa, ma a quella dello Stato. Il quale sceglie sotto la sua totale responsabilità, in base a criteri laici, cioè razionalmente condivisibili da chiunque usi rettamente la sua ragione. Dunque l'autorità ecclesiastica non deve sentirsi in colpa, nella fattispecie verso i mussulmani, come se fosse lei a ispirare le leggi dello stato. Non si tratta qui di un problema di dialogo inter-religioso, ma di un problema politico: uno Stato, un sistema politico-istituzionale, che sentendosi, a torto o a ragione, minacciato nelle sue stesse fondamenta, adotta, in base a regole trasparenti e universalmente condivise, poggianti sul consenso popolare e non su un mandato ecclesiastico, dei provvedimenti che rientrano nella sfera "di Cesare" e non in quella "di Dio". Se è vero che il laicismo è un male, vi è una corretta idea di laicità, che è la applicazione pratica di quell'idea che garantisce un enorme vantaggio al Cristianesimo cattolico sulle "religioni", l'idea di distinzione e armonia tra fede e ragione. Solo il Cristianesimo cattolico può vantare una non mutilazione della ragione, ma una sua piena valorizzazione. Non bisogna perciò avere paura di ammettere un livello basato su una sana ragione, condivisibile da tutti gli uomini che ben ragionino, e non dunque dai soli credenti. Il caso del chador, o comunque (visto che ci teniamo un margine di dubbio sul caso specifico di questa scelta) il caso di un intervento degli stati occidentali che argini la diffusione di concezioni politicamente intolleranti è proprio il caso di una applicazione della ragione, di una ragione laica, nel senso buono del termine. Paradossi, per capirciPotremmo allora definire per paradossi (fantapolitici, ma non poi più di tanto) la laicità così intesa. Essa è quel principio in base al quale non si potrebbe permettere a una religione "detassista" (che dicesse che è contrario ai suoi principi religiosi pagare le tasse) di pretendere che i suoi adepti non paghino le tasse; è quel principio in base al quale non si potrebbe permettere a una religione "primogeniticida" di sacrificare al suo "dio" ogni primogenito. Sarebbero casi di violazione della libertà religiosa? No, perché ciò che si proibirebbe sarebbe la violazione di diritti umani fondamentali, riconoscibili da una retta ragione, riconoscibili cioè laicamente, secondo una corretta idea di laicità. Insomma, deve essere chiaro che non basta che uno dica che un certo comportamento è religioso, perché tale comportamento diventi ipso facto insindacabile e sottratto alle comuni leggi che regolano l'umana convivenza. E proprio nel DNA del cattolicesimo c'è tutta la forza per accettare questa sfida, la sfida di non sottrarsi al criterio dell'umano, del ragionevole, sapendo che la verità di cui è portatore è più umanamente vera di qualsiasi fanatismo e di qualsiasi pseudo-umanesimo ateo. Alternative e prioritàCerto, molto meglio sarebbe, se invece che proibire il velo, o invece che considerare quello come una priorità, si desse importanza prioritaria a una forte e sistematica rivendicazione del principio di reciprocità, chiedendo che i paesi a maggioranza islamica concedano altrettanta libertà religiosa quanta ne concedono i paesi occidentali. Ma la politica è l’arte del possibile, e oggi come oggi, da questo Occidente, ci si può aspettare più una reazione di (egoistica) autodifesa, che una (altruistica e lungimirante) difesa dei deboli lontani. Temi correlatiPer capire meglio quanto qui abbiamo detto si può anche vedere qualcosa sul tema del rapporto, per così dire triangolare, tra Cristianesimo, Occidente e Islam, nell'attuale ora storica [vai]. In effetti il giudizio implicitamente sotteso a certi tipi di critica cattolica alla scelta francese è che, di fronte a un Occidente secolarizzato e decadente, convenga ai credenti puntare su una sorta di alleanza con quell'Islam, che è una forza fresca e religiosa. Come dire: noi siamo religiosi, loro sono religiosi, dunque mettiamoci insieme contro l'Occidente corrotto e ateo. Ora, se è vero che su alcuni temi (la difesa della vita, la lotta alla manipolazione genetica, alla pornografia e alla banalizzazione del sesso e simili) può verificarsi una, utile, convergenza tattica, come già avviene in sedi internazionali tra il Vaticano e paesi a maggioranza islamica, resta il fatto che, su un piano globale quel giudizio è ampiamente inadeguato.
Per uno sviluppo di questo tema si veda il contributo accennato. In sintesi
[1] Forse la memoria di molti è andata addirittura all’odio anticristiano che guidò i massacri dei cattolici vandeani, alla persecuzione cruenta del clero refrattario e giù di lì. Ecco allora Chirac come un nuovo Robespierre, la Quinta Repubblica come la Prima: una volontà di vessare e opprimere il fenomeno religioso, e segnatamente cristiano. Lo pensiamo per spiegarci il carattere virulento di certe reazioni, che nulla hanno concesso di positivo alla decisione francese. [2] Questo è reso possibile dal fatto che Dio si è fatto Uomo, ha manifestato il Suo Volto in una carne, a cui si poteva e si può dire TU. Così, completando un cammino di costituzione dell’io personale iniziato con Abramo, si costituisce pienamente l’io, la persona come capacità di rapporto, appunto personale, col Mistero. [3] Si noti che il sufismo è comunque un fenomeno in qualche modo ereticale dell’Islam. [4] Con pena di morte de un mussulmano viene ucciso da un non-mussulmano, e semplice condanna pecuniaria se accade il contrario. [5] Nel caso di “bestemmia” contro il Profeta. Concetto reintrodotto negli ultimi anni anche in Pakistan, generando uno stato di disperazione tra i cristiani del luogo, in balia dell’arbitrio totale delle autorità islamiche. Anche perché in realtà per bestemmiare basta semplicemente non credere in quello che ha detto il Profeta, cioè basta non essere mussulmani. [6] Intervista su Avvenire, venerdi 23 gennaio 2004, da cui citeremo. [7] Così come potrebbe dire un cristiano “io voglio cristianizzare questa terra”. Più in generale, chiunque ha una certa idea, desidera che tale idea vinca: ma bisogna poi vedere ricorrendo a quali mezzi, e se lo voglia accettando o meno la libertà delle persone. [8] Non possiamo non pensare a Bacone: “citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione”. Occidente e Islam torna su di F.B. Una tesi che circola, in alcuni ambienti cattolici, sul rapporto tra Occidente e Islam è che occorra tenere ben distinti Occidente e Cristianesimo, salvaguardando quest’ultimo, ma giudicando il primo, per come è oggi, al culmine di un lungo processo di scristianizzazione giunto ormai al nichilismo più spinto, indifendibile e meritevole di essere abbandonato al suo destino, per riconoscere invece qualche benemerenza all’Islam, che, se non altro, ateo e nichilista non è, e può persino dare una mano a un recupero della Trascendenza. Così, ad esempio Michele Brambilla, brillante giornalista e saggista, ha sostenuto recentemente, nel corso di una nota trasmissione radiofonica, che l’impatto con l’Islam deve essere per l’umanità occidentale occasione per recuperare quei valori che in questi ultimi decenni sono stati abbandonati, col risultato che l’Occidente si trova ad essere sì tecnologicamente, economicamente e militarmente forte, ma moralmente debole e intimamente infelice. Dunque, prima e piuttosto che accusare l’Islam che ci minaccia, pensiamo ad essere un po’ più bravi noi. A nulla infatti servirà la superiorità materiale, se non ci sarà un recupero di saldezza morale e spirituale. Non si vuol dire che tali tesi non contengano una parte di verità: è vero che l’Occidente, nelle sue élites fin dagli albori dell’epoca moderna, e in modo sempre più radicale e diffuso dopo la rivoluzione francese, si è allontanato dal Cristianesimo e così facendo ha sperperato la sua ricchezza più preziosa. Tuttavia ci sono dei notevoli limiti in una impostazione che riduca la questione in tali termini. Anzitutto perché facilmente può istituire un cortocircuito moralistico: come se si trattasse di raggiungere un certo “livello morale”, sotto il quale non si sarebbe degni di dire alcunché e nemmeno di autodifendersi. Ora, come già osservava Hegel contro Kant (l’interminabile duello allo specchio per raggiungere l’inarrivabile adeguazione tra essere e dover essere), il moralismo è un gorgo vorticoso da cui è impossibile uscire, senza metterne radicalmente in discussione lo stesso principio, che cioè il problema sia quello di conformarsi a una legge astratta. Un autoavvitamento moralistico dell’Occidente è del resto improponibile per varie ragioni: prima di tutto perché è ingiusto, in secondo luogo perché è o inutile o (potenzialmente) dannoso. Ingiusto: perché non è il metodo adeguato per proporre quella pienezza di umanità, che è la sola degna meta di un cammino morale; non si tratta di essere “più bravi”, più coerenti moralmente, spinti come muli, frustati dall’urgere di circostanze esterne. E poi, o inutile o dannoso: inutile in quanto l’umanità occidentale ha dimostrato per due secoli di essere, in nome della “libertà”, sorda a un richiamo moralistico, quale è stato purtroppo troppo spesso quello risuonato nelle chiese, anche in quella cattolica; dannoso, in quanto semmai un tale richiamo avesse effetto, avrebbe come conseguenza quella di disarmare quella lucidità di vigilanza e quella prontezza di riflessi che sono tanto più necessarie in quest’ora di serissime minacce terroristiche. Tutti presi dalla smania di autocorrezione moralistica, gli occidentali sarebbero propensi a minimizzare e perdonare qualsiasi cosa, se non addirittura a considerarla come salutare purificazione. Ciò detto, resta da vedere quale valutazione si possa dare dell’Occidente in merito al suo legame col Cristianesimo. Se la distinzione tra Occidente e Cristianesimo è indiscutibile, per i motivi già accennati e che sono da molto tempo opinione largamente condivisa dentro e fuori del mondo cattolico, resta da vedere quanto resta, in questo mondo secolarizzato e disparatamente nichilista, di quel Cristianesimo che ne è comunque stato il fondamento e l’anima. Personalmente ritengo che vi sia più eredità cristiana di quanto non si ammetta comunemente, anche nel pensiero e nelle manifestazioni più dichiaratamente atee e nichiliste dell’Occidente. Al di là, ripeto, della esplicita autocoscienza di gran parte dell’Occidente. L’Occidente deve molto al Cristianesimo: il senso della persona come valore infinito, e al contempo il valore della solidarietà verso tutti e non solo verso chi appartiene alla Umma, il senso del lavoro come operosità positivamente costruttiva, la stima per la razionalità, da cui è nata la scienza, il valore della donna, il senso della giustizia sociale, per non citare che alcune delle maggiori idee di cui l’Occidente è debitore, seppur ingrato, al Cristianesimo. In un certo senso si potrebbe dire che tutto quanto di positivo e di costruttivo sia stato affermato dall’Occidente sia di matrice oggettivamente cristiana, a dispetto dei ciclopici tentativi, fatti nel XIX e XX secolo, per strapparsi di dosso tale marchio. Troppo spesso invece, nel mondo cattolico, si è avuto uno sguardo sussiegoso, incapace di valorizzazione e di recupero del positivo, una sdegnosa schizzinosità: verso la scienza prima, verso il mercato e la ricerca del benessere poi, e dopo ancora verso la democrazia e la giustizia sociale. Ciò che era oggettivamente figlio, è stato ripudiato e spinto lontano. O, almeno, non è stato riconosciuto come figlio, aiutandolo a correggere i propri errori, che certo c’erano e non erano pochi. Per dirla con Eliot (Cori della Rocca), se in parte è stata l’umanità ad abbandonare la Chiesa, in parte è stata però la Chiesa ad abbandonare l’umanità (occidentale), bacchettandone gli errori piuttosto che tentando di incanalarne il positivo in una orientazione pienamente costruttiva. Non è detto infatti che lo Spirito soffi solo su chi ha … la tessera dell’Azione cattolica o frequenti l’Oratorio con devota ossequiosità. Quante volte un atteggiamento clericale, così splendidamente condannato da Péguy, non ha aiutato a riconoscere anche nel grido di un ateo un brandello di verità. Ci sono volute, nel XX, intelligenze come don Giussani e de Lubac hanno saputo trovare del vero anche in atei, come Leopardi, o Nietzsche, o Pascoli, o Pasolini. [Oggi, anche le parole di Benedetto XVI, in dialogo e in ascolto di chiunque cerchi la verità, rovesciando l’assioma degli illuministi, l’etsi Deus non daretur nel cui segno nasce la modernità, poiché “anche chi non riesce a trovare la via dell’accettazione di Dio dovrebbe comunque cercare di vivere e indirizzare la sua vita veluti si Deus daretur, come se Dio ci fosse”.ndR] In un certo senso, in effetti, ci sembra che l’Occidente, anche in molte sue proposte che dicono di rinnegare il Cristianesimo, sia comunque più vicino, dialetticamente se non staticamente, al Cristianesimo, di quanto non lo sia il più devoto mussulmano. Usiamo i termini dialettico e statico nel senso usato da Kierkegaard: statica è la distanza di fatto in un certo momento, senza che sia dia possibilità di modifica, dialettica è quella che facilmente potrebbe cambiare, ove intervenissero (come possibile, se non probabile) certe condizioni. Così una moglie che abbia litigato aspramente col marito è staticamente più vicina al primo passante che incontra, ma dialetticamente resta comunque più legata al marito, nel senso che potrebbe bastare un attimo, la parola giusta, lo sguardo giusto, per riavvicinarla al marito, mentre col primo che passa, pur non essendoci ostilità, c’è comunque una estraneità di fondo. Si badi: non stiamo parlando dell’intenzione morale delle singole persone, della loro qualità morale, per così dire; non stiamo dicendo che gli occidentali religiosamente indifferenti siano in quanto tali e comunque più buoni degli islamici più devoti; stiamo parlando di un substrato culturale, di idee, che sostanziano delle mentalità, in qualche modo malgrado i singoli. Così ci sembra che i funerali dei morti di Nassyria abbiano dimostrato che, almeno in Italia, sotto la cenere di un apparentemente totalizzante nichilismo consumista, vive una insospettata brace di nostalgia per una tradizione, a cui molti, più di quanto non si potesse pensare, non vogliono rinunciare soprattutto ora che essa appare drammaticamente minacciata. [Anche se siamo ben lontani dall'approvare la cosiddetta "guerra giusta" ndR] Più in generale dopo l’11 settembre ho l’impressione che anche sotto certe forme, che in passato si sarebbero più tranquillamente definite come beotamente superficiali, come il luccichio (letterale e metaforico) natalizio, si celi, almeno per molti, un inespresso e implicito bisogno di una tradizione, che evidentemente desta uno struggimento di nostalgia. La stessa moda delle piccole croci al collo, non saremmo così sicuri che non esprima in molti casi, per quanto rozzamente e incoscientemente, una oggettiva nostalgia identitaria, il cui nocciolo positivo sarebbe più saggio recuperare che reprimere. Ci sembra in effetti che il compito di chi ha una coscienza più matura e lucida non sia quello di sferzare questi timidi, balbettanti e magari contorti vagiti, ma di offrire loro l’aiuto di una testimonianza di pienezza umana, perché diventino un primo ponte verso un recupero totale del loro Fondamento adeguato. Tutto questo non toglie che ci sia anche una cultura occidentale, lucidamente anticristiana, e vaccinata a ogni ritorno alla Verità su cui si è costruita l’Europa, una cultura sazia del proprio nichilismo e del proprio cinismo. È chiaro che questo settore è di per sé indifendibile. Se non che da un lato questa cultura si intreccia nelle stesse persone e negli stessi gruppi con quel residuo di nostalgia cristiana non priva di aperture, di cui abbiamo sopra detto; e d’altro lato, nella misura in cui essa si presenta allo stato puro, è proprio questa cultura lucidamente e cinicamente anticristiana a proporre un abbraccio con quell’Islam più anticristiano, in funzione di una espulsione di Cristo dalla realtà concreta dell’Europa. Non si tratta allora di puntellare qualcosa di immorale, un Impero decadente che starebbe cadendo sotto la pressione delle forze fresche e vitali dei nuovi barbari, ma di aiutare l’Occidente a ritrovare le sue più vere radici, non insistendo tanto sull’osservanza di leggi e di valori, che rischierebbe un inconcludente e stantio moralismo, ma testimoniando che quella Novità imprevedibile che l’ha plasmato è ancora viva, “ieri oggi e sempre”, con la sua forza umanizzatrice, con quella pace e quella gioia “che il mondo non può dare” e che altrove invano si cercherebbe. _________________ [Fonte: Culturanuova.net] -->scrivete un vostro commento--<
|
|